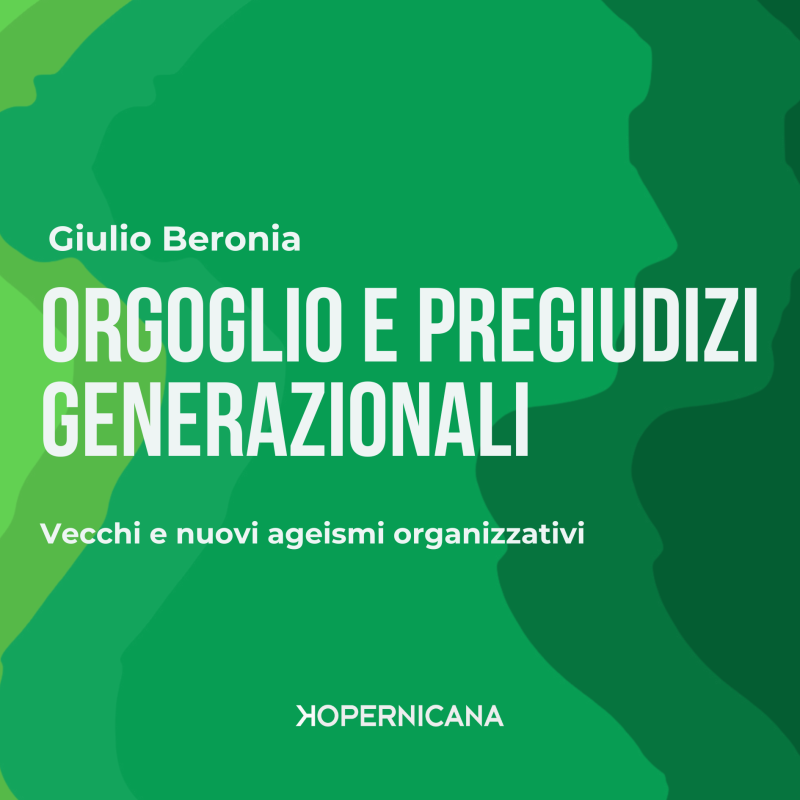Quando proviamo a chiedere in azienda se le persone sono favorevoli a lavorare con generazioni distanti dalle proprie, spesso i risultati di survey interne e focus group qui in Italia restituiscono feedback positivi (e anche in buona parte confortanti) sia tra giovani, sia tra adulti. Poi proviamo a fare un giro nelle mense o alle feste aziendali, oppure inneschiamo nella formazione la costruzione di gruppi di lavoro, e scopriamo che fisiologicamente le persone di età simile tendono a stare insieme, a collaborare con più enfasi e a condividere senza filtri gioie, gossip e dolori della quotidianità lavorativa.
Quando progettiamo piani di carriera, programmi di welfare, piani di retribuzione, progetti di innovation, implementazione di nuove piattaforme digitali, ma anche strategie di business o banalmente le newsletter aziendali (e potrei continuare ancora, e ancora), forse siamo convinti che la variabile delle età non sia così importante. Eppure.
Quando progettiamo piani di carriera, programmi di welfare, piani di retribuzione, progetti di innovation, implementazione di nuove piattaforme digitali, ma anche strategie di business o banalmente le newsletter aziendali (e potrei continuare ancora, e ancora), forse siamo convinti che la variabile delle età non sia così importante. Eppure.
I bias inconsci sono distorsioni di giudizio, molto spesso non intenzionali e profondamente radicati, che sono in grado di influenzare il nostro comportamento, così come le scelte organizzative e la cultura aziendale. E l’ageismo, che si riferisce agli STEREOTIPI (come pensiamo), al PREGIUDIZIO (come ci sentiamo), e alla DISCRIMINAZIONE (come agiamo), rivolti alle persone in base alla loro età – sia verso gli anziani, sia verso i giovani – è ben presente sul lavoro, come sottolinea la World Health Organization in un ultimo report del 2021: oltre il 50% dei giovani di 15-24 anni si sente trattato con mancanza di rispetto (ignorato o vittima di paternalismo), così come un buon 40% di adulti over 65, e in entrambi i gruppi circa un 30-40% si considera trattato molto male (insultato o “abused”) per la propria età.
L’ageismo, in fondo, è ancora socialmente accettato a causa della sua natura implicita e subconscia, e forse perché si tratta di un concetto relativamente nuovo nella società, oltre che nella cultura organizzativa. La classificazione di un individuo sulla base dell’età non è statica, ma cambia nel corso del ciclo di vita, mentre quella che assume ad oggetto altri temi identitari (come, ad esempio, l’etnia o il genere) rimane costante, e tende ad essere molto più polarizzata anche a livello mediatico.
L’ageismo, in fondo, è ancora socialmente accettato a causa della sua natura implicita e subconscia, e forse perché si tratta di un concetto relativamente nuovo nella società, oltre che nella cultura organizzativa
Ma quali sono allora gli errori di giudizio che commettiamo solitamente al lavoro verso i gruppi minoritari di età?
Rispetto alla popolazione senior la tendenza è quella di considerare i lavoratori più anziani meno motivati, meno desiderosi di partecipare ad aggiornamenti per lo sviluppo di carriera, più resistenti al cambiamento e meno affidabili, meno sani e meno capaci di gestire il rapporto tra vita lavorativa e vita privata. Le ricerche di psicologia sociale più accurate riscontrano, invece, che un unico stereotipo coerente con l’evidenza empirica è quello che riguarda la minore volontà dei più anziani di partecipare a corsi di aggiornamento e ad attività tese allo sviluppo di carriera (cfr. Thomas W. H. Ng,Daniel C. Feldman, ”Evaluating Six Common Stereotypes About Older Workers with Meta-Analytical Data”, 2012).
C’è da dire, ça va sans dire, che la prospettiva di futuro in azienda è oggettivamente differente per taluni; quindi, è inevitabile un abbassamento dell’engagementi di questo tipo, al netto di immaginare dei seri approcci di new longevity economy in ogni realtà organizzativa.
Ma quali sono allora gli errori di giudizio che commettiamo solitamente al lavoro verso i gruppi minoritari di età?
Verso i giovani invece abbiamo un tripudio di giovanilismi e “sindromi di Dorian Gray” che derivano dai cambiamenti culturali che negli ultimi decenni Baby Boomer e X Generation hanno diffuso nei corridoi aziendali. In primis, capovolgendo l’immaginario collettivo della persona matura che da saggio rispettato e riverito è diventato un “matusa” rimbambito; ma anche dalla corrente che negli anni ’90, all’insegna del “cambiamo tutto”, inseguendo la globalizzazione dei mercati, ha diffuso il cliché che il talento è esclusivamente un giovane: da attrarre, motivare e far crescere, innescando il culto degli “alti potenziali”. Da qui il falso mito del “giovane che è aperto all’innovazione”, “è nativo digitale quindi padroneggia bene tutti gli strumenti tecnologici” o, peggio, “al futuro dell’azienda ci pensano i giovani”, “ora arrivano i giovani che hanno nuove energie” e così via. Salvo poi accorgerci che, quando questi preconcetti si scontrano con realtà differenti, si alimentano nuovi stereotipi di giovani pigri, superficiali, inetti o stupidamente ribelli.
Verso i giovani invece abbiamo un tripudio di giovanilismi e “sindromi di Dorian Gray” che derivano dai cambiamenti culturali che negli ultimi decenni Baby Boomer e X Generation hanno diffuso nei corridoi aziendali
Purtroppo, quando parliamo di generazioni in azienda, non stiamo centrando interamente il problema, per mille motivi: il concetto di generazione è una specie di iper-coorte, che dovrebbe distinguersi per la profondità degli elementi storici, sociali e culturali che tengono insieme chi ne fa parte.
Ma negli ultimi tempi la “generazione” è diventata una coorte anagrafica dall’ampiezza fissa (intorno ai quindici anni) che scandisce le persone e i consumatori. Oggi questo schema ha la lettura delle matrici statistiche con cui la cultura anglosassone ama descrivere il mondo, belle precise e omologate. Funziona indubbiamente per identificare queste categorie in senso statistico, storico, culturale, merceologico, diremmo “macro”, ma a volte meno in termini strettamente organizzativi. A volte, è più facile che un Boomer e un Gen Zed che vivono la stessa cultura aziendale si somiglino e vadano “d’accordo” molto più che gli stessi personaggi generazionali intervistati al di fuori del perimetro organizzativo!
Poiché le categorie generazionali non sono definite scientificamente (l’unica modalità sembrerebbe misurare gli effetti della generazione utilizzando l’analisi di età-periodo-coorte, ma rimane una pratica onerosa e comunque incompleta), le etichette generazionali possono portare a stereotipi e semplificazioni eccessive, funzionando in una certa misura solo per quella parte di mondo che conosce la cultura occidentale e ne è influenzata, e le discussioni sulle generazioni spesso si concentrano sulle differenze invece che sulle somiglianze (o viceversa!).
Poiché le categorie generazionali non sono definite scientificamente le etichette generazionali possono portare a stereotipi e semplificazioni eccessive
Quali sono allora le chiavi di lettura strategica da assimilare quando parliamo di pregiudizi generazionali?
Senz’altro leggere attraverso la lente delle generazioni (declinata però in ogni singola realtà organizzativa), ci aiuta ad esplorare quanto davvero cambi in termini valoriali l’etica del lavoro in termini di identità professionale e personale, quali sono le differenze rispetto a fiducia e lealtà verso il brand, di approcci alla leadership, di orientamento ai risultati e senso del “sacrificio”, e così via (cfr. XYZ@Work 2020 Multigenerational Workforce Study).
Da alcuni studi più manageriali a livello internazionale e nazionale, si riscontra ripetutamente quanto le sfide e le sensazioni di “discriminazione” rispetto alle età nelle organizzazioni aziendali siano piuttosto ricorrenti secondo la generazione di appartenenza: la Gen Z ha paura di essere sottovalutata e non ascoltata a causa della mancanza di esperienza, di essere percepita come viziata e impaziente e di avere opportunità di crescita limitate; i Millennials temono di rimanere schiacciati tra le diverse generazioni e iniziano ad avere grosse difficoltà di conciliazione lavoro e famiglia e di stabilità economica; la Gen X di essere al culmine e di aver “toccato il soffitto” in termini di avanzamento di carriera e guadagno potenziale insieme al sentitissimo tema di conciliazione del caregiving dei parenti più anziani; i Boomers con il cruccio di non riuscire a superare i propri vecchi modelli mentali, di non avere abbastanza padronanza delle conoscenze digitali e di non riuscire ad imparare velocemente per confrontarsi con le generazioni più giovani.
Ma contemporaneamente è indispensabile iniziare a ragionare con i paradigmi del tempo, dell’età e dei cicli di vita se ci occupiamo di People & Culture in azienda. Iniziamo quindi a fare entrare un po’ di studi demografici in azienda: quante realtà, ad esempio, riescono a dichiarare senza vergogna nelle proprie career page l’età media della propria popolazione o qualche altra informazione sulla composizione demografica delle persone che contribuiscono a rendere l’employer brand aziendale quello che è?
Iniziamo quindi a fare entrare un po’ di studi demografici in azienda...
“Toma mucho tiempo llegar a ser jóven” diceva Picasso e, come in tutti i cambiamenti e le rivoluzioni organizzative, è necessario sicuramente agire sul piano culturale, attraverso il confronto, l’awareness e la formazione sull’inclusione generazionale, ma contemporaneamente riflettere sui processi, sulle policy, sulla employer value proposition, sugli organigrammi e i team di lavoro per comprendere “dove stiamo compiendo ageismi” verso i giovani e verso i più anziani.
Ecco che allora approcciarsi alle workforce strategies generazionali non significa fare solo un lavoro di Diversity Equity & Inclusion, provando a far mettere da parte orgogli e pregiudizi collegati all’età sul lavoro, ma soprattutto rileggere il lavoro attraverso le lenti DELL’età, e DELLE età in azienda.
Ad oggi non possiamo che aggiungere al mantra HR che ci ricorda di mettere al centro dell’organizzazione persone e cultura anche il focus sul tempo e i tempi che colleghe e colleghi abitano nel ciclo di vita organizzativo.